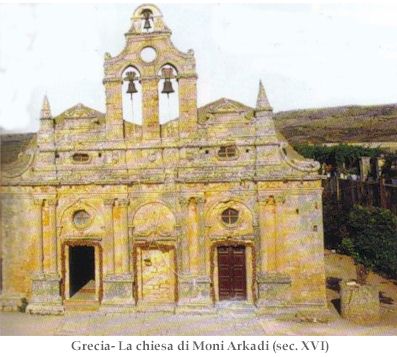STORIA-ARTE
La nascita della Grecia cristiana si può far risalire alla
perfetta fusione del cristianesimo con la componente politica romana e quella
culturale ellenistica operata da Costantino (307-337). Fu lui a
 convocare il primo concilio ecumenico
- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a
trasferire la capitale a Costantinopoli (330).
Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente
greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si
celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria
Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i
tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da
Bisanzio in particolare.
convocare il primo concilio ecumenico
- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a
trasferire la capitale a Costantinopoli (330).
Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente
greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si
celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria
Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i
tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da
Bisanzio in particolare.
Da templi pagani a chiese dedicate alla Vergine
Molti templi pagani dell'antica Grecia
vennero trasformati in chiese cristiane e spesso dedicate alla Vergine. Ad Atene, centro culturale prestigioso e
ancora animato da pensiero pagano, il celebre Partenone, tempio di Atena, dea
della sapienza, nel 432 venne dedicato alla Santa Sapienza ("Aghia
Sofia": il Verbo, Cristo), apportandovi solo delle lievi modifiche
all'interno. Tuttavia il culto mariano
vi divenne prevalente e nel 662 si ebbe una nuova dedicazione: la Vergine era
invocata nel tempio come "Panaghia Ateniotissa" (la Tuttasanta di
Atene): in pratica il culto a Maria venne a rimpiazzare quello ad Atena. Il
termine "Tuttasanta" ("Panaghia"), è quello corrente in
Grecia per indicare e invocare Maria e corrisponde in pratica al nostro
"Madonna".
A
difesa di Costantinopoli
Durante gli oltre mille anni di vita
dell'impero romano d'Oriente, la Grecia propriamente detta perse quasi del
tutto la sua importanza politica e culturale, il centro dell'impero divenne
Bisanzio, l'odierna Istanbul, fonte inesauribile di cultura e
fondamentale centro di diffusione del culto mariano. Costantinopoli nel corso della sua lunga
storia subì ben trenta assedi, ma cadde solo due volte. Resistette tante volte
ai nemici, grazie alla saldezza delle mura e al famoso "fuoco greco",
una miscela incendiaria rimasta a lungo segreta, ma, secondo gli abitanti della
città, grazie anche alla costante
protezione della Vergine.
Costantinopoli, che stando all'ammirata
testimonianza dei viaggiatori e mercanti medioevali «aveva più chiese che i giorni dell'anno», ne contava almeno
settanta dedicate alla Vergine. Di queste chiese, quattro, e tutte risalenti al
V secolo, ebbero un'importanza eccezionale, non solo dal punto di vista della
devozione, ma anche dell'arte, della liturgia e della stessa storia: Blakernes,
la Kalkopratia, l'Odigitria e la Fonte di Vita.
La chiesa più celebre era Blakernes, posta
ad angolo fra l'insenatura del porto
(il Corno d'Oro) e le mura.In essa si conservava una celebre reliquia
mariana , la "veste" della Vergine, trafugata dalla Terra Santa nel
471. All'intercessione della "Blakerniotissa" (Beata Vergine di Blakernes)
si attribuiva la salvezza dai tantissimi pericoli corsi dalla città e
dall'impero, tanto che ella era invocata come "Stratega Protettrice",
una specie di giudice dei soldati per difendere la patria.
Nella chiesa della Kalkopratia si venerava
un'altra celebre reliquia, il "cinto" della Vergine. L'Odigitria
invece aveva al centro del culto l'icona omonima. Divenne famosa perché
attribuita a san Luca. Tutte le Odigitrie che si venerano sia in Oriente che in
Occidente hanno quest'immagine come prototipo; da essa derivano anche tutte le
tradizioni che attribuiscono al terzo evangelista le immagini venerate in tanti
santuari. Il quarto santuario, Maria Fonte di Vita, è
l'unico tuttora esistente; ha come centro di culto una fonte sacra. In tutto
l'Oriente e nello stesso Occidente sono sorti numerosissimi santuari con la stessa denominazione di quelle di
Costantinopoli.
La
guerra contro le immagini
A questo inizio così trionfale del culto
mariano seguì la violenta bufera dell'iconoclastia o lotta contro le immagini,
divampata tra il 726 e l'843, anno in cui l'imperatrice Teodora, convocò un
concilio a Costantinopoli e ristabilì ufficialmente il culto delle immagini.
In tale periodo invano si opposero
all'imperatore l'ultimo dei padri della Chiesa, san Giovanni Damasceno, il papa
di Roma e i monaci: molti di questi ultimi subirono il martirio.
La maggior parte delle immagini (icone
portatili, affreschi e mosaici) furono distrutte inesorabilmente, con un danno
enorme non solo per la devozione, ma anche per la cultura, e con la perdita di
moltissime opere del periodo più fiorente dell'arte bizantina. Alcune immagini
si s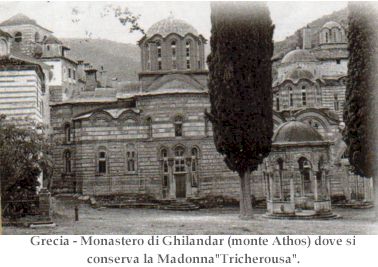 alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così
origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile
orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo
vigore. Lo stile tuttavia si modificò
sensibilmente; si fece severo e in qualche modo anche ripetitivo. La sontuosità delle opere dei secoli
precedenti cedette il passo ad una composta semplicità.
alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così
origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile
orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo
vigore. Lo stile tuttavia si modificò
sensibilmente; si fece severo e in qualche modo anche ripetitivo. La sontuosità delle opere dei secoli
precedenti cedette il passo ad una composta semplicità.
Il
monte Athos con i « giardini di Maria»
Dopo la crisi iconoclasta cominciò l'ascesa
del monte Athos, ribattezzato come "Santa montagna” cuore spirituale,
culturale e artistico di tutto l'Oriente ortodosso, a partire dal mille fino a tutt'oggi.
Il
Monte Athos ha tutta una serie di santuari, per cui è chiamato i
"Giardini di Maria". Situato su una piccola e suggestiva penisola
delle Cicladi, tutta foreste e scogliere a picco sul mare, è popolato a partire
dai secoli VI-VII esclusivamente da monaci, i quali raggiunsero, nel 1400, il
numero di 40 mila. Oggi sono circa 1200 e vivono in venti monasteri, in eremi
e celle, seguendo speciali leggi e tradizioni. La loro devozione è molto viva
e viene espressa nella preghiera liturgica con lunghe ufficiature, con la
recita dell'inno Acatisto, con processioni dietro icone mariane e con
pellegrinaggi da una comunità all'altra, in date stabilite, per venerare
particolari immagini della Vergine. Inoltre essi fanno a gara per dipingere
icone mariane dai titoli più diversi: Kyriotissa (la Sovrana), Nicopéia
(la Vittoriosa), Odigitria (la Indicante la via per Cristo), Eleùsa
(la Tenerezza), Basilissa (la Regina), Platìtera (la più ampia
dei cieli), ecc., per diffondere poi nel mondo e soprattutto tra i loro ospiti.
In ogni monastero vi è quindi
abbondanza di
icone mariane, che sono considerate dai monaci segno visibile del mondo
spirituale, ma ve n'è più di una che è venerata in modo speciale da tutti. La Panaghia
Tricherousa, la "Madonna delle tre mani”, è una delle più celebri per
la presenza in basso di un ex voto a forma di mano e perché, secondo la
tradizione, fu fatta dipingere da S. Giovanni Damasceno in ringraziamento alla
Vergine per avergli miracolosamente riattaccato la mano destra fattagli
tagliare da un califfo iconoclasta. L’Axion Estin (“E’ degno”) -nome
derivato dalle prime parole di una preghiera rivolta alla Vergine e insegnata a
un monaco da un angelo -è un’icona considerata la patrona dell’Athos. La Gorgoepikoos
è la Vergine “Pronta all’ascolto”,
venerata nel monastero di Dochiariu, mentre in quello di Gregoriou è custodita
la Galactotrofusa, cioè la Vergine nell’atteggiamento di nutrire col suo
latte il Bambino Gesù. Nella piccola cappella del monastero di Vatopädi, dove i
monaci sono soliti emettere i loro voti, è dipinta la Panaghia Paramythia, l’Avvocata
o la Vergine del conforto, alla quale è legata una singolare leggenda.
Le Meteore
Un
luogo mariano molto simile al Monte Athos è costituito dalle Meteore, monasteri
appollaiati in cima a rocce che si elevano perpendicolari dalla pianura della
Tessaglia. I monaci incominciarono a dimorarvi dall'XI secolo e raggiunsero il
massimo sviluppo con venti-trenta monasteri nel secolo XIV, mentre oggi se ne
contano solo sei. La lode alla Madre di Dio è quotidiana sia privata che nelle
lunghe ufficiature liturgiche in comune, e l'arte pittorica la riflette nelle
icone, negli affreschi, in miniature e in ricami su paramenti sacerdotali. Tra
le icone più venerate figurano la Madonna delle lacrime del secolo XIV
nel monastero della Grande Meteora e la Vergine in trono del
secolo XVI nella chiesa del monastero di Barlaam .
Sotto
il giogo turco
Alla dissoluzione dell'impero latino
d'Oriente (1261) fece seguito un periodo di guerre civili che indebolirono
l'impero d'Oriente favorendo l'avanzata ottomana. Il 29 maggio 1453, le truppe di Maometto II
presero d'assalto Costantinopoli, e successivamente la saccheggiarono facendo
strage degli abitanti. Nei giorni
precedenti si erano avute solenni processioni penitenziali recanti per le vie
della città l'icona dell'Odigitria, ma l'ora di Costantinopoli era
segnata. Comunque i turchi si
affrettarono a profanare e distruggere l'icona, quasi a voler annientare, con
tale gesto, la speranza dal cuore dei fedeli superstiti. Le chiese della città,
diven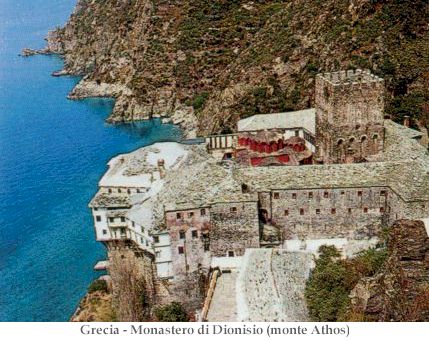 uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee
o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole
dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di
loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi. Molto venerata fra di loro era l'icona "Kardiotissa",
avente per prototipo la Madonna del perpetuo soccorso, situata nella chiesa di
Sant'Alfonso de' Liguori a Roma.
uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee
o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole
dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di
loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi. Molto venerata fra di loro era l'icona "Kardiotissa",
avente per prototipo la Madonna del perpetuo soccorso, situata nella chiesa di
Sant'Alfonso de' Liguori a Roma.
I marinai invocavano la Vergine
attribuendole appellativi curiosi e suggestivi che ricordavano un po' tutti gli
aspetti della vita di mare: lei era "Colei che tiene saldo l'albero",
la "Marinara", la "Capitana", "Colei che lotta contro
le onde", ecc. Il santuario greco più celebre del periodo turco era quello
di Sifronos, un'isola delle Cicladi; esso, prima dell'ascesa di Tinos,
rappresentava in qualche modo il santuario mariano nazionale.
L'Annunciazione
come festa nazionale
La lotta per l'indipendenza della Grecia,
iniziata nel 1821 e protrattasi per vari anni fra alterne vicende, fu
indissolubilmente legata ad alcuni aspetti del culto mariano, anche per
quell'inestricabile intreccio di religione e politica che è caratteristico
della cristianità orientale.
I rivoluzionari si legarono con giuramento
in un santuario mariano del Peloponneso (Aghia Lavra); molti di loro fecero e
mantennero poi dei voti in onore della "Tuttasanta"; inoltre fu
scelto proprio il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, come ricorrenza
nazionale. Grande risonanza ebbe poi il
rinvenimento dell'icona di Tinos, avvenuta nel 1824, proprio nel pieno della
lotta contro i turchi; ne sorse un santuario che divenne ben presto il più
frequentato della nazione.
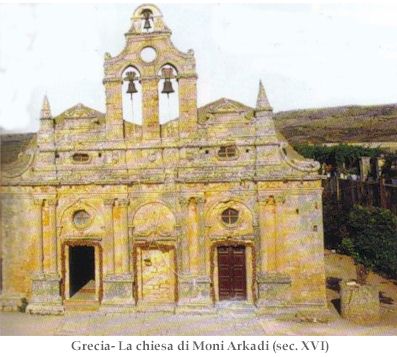
 convocare il primo concilio ecumenico
- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a
trasferire la capitale a Costantinopoli (330).
Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente
greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si
celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria
Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i
tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da
Bisanzio in particolare.
convocare il primo concilio ecumenico
- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a
trasferire la capitale a Costantinopoli (330).
Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente
greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si
celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria
Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i
tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da
Bisanzio in particolare.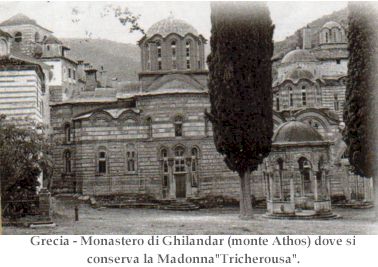 alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così
origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile
orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo
vigore.
alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così
origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile
orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo
vigore.
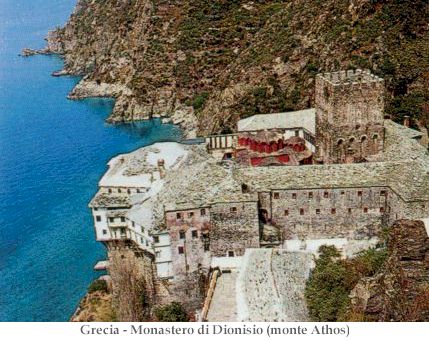 uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee
o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole
dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di
loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi.
uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee
o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole
dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di
loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi.